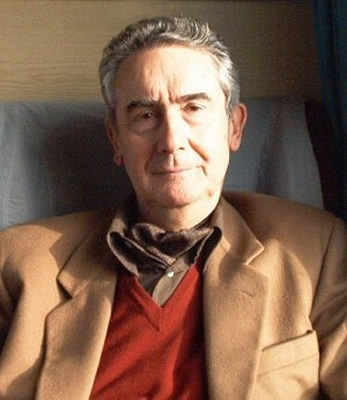|
Nell’oceano del lavoro la tempesta deriva dall’aver messo in
competizione tra loro, deliberatamente, il mezzo miliardo di lavoratori
del mondo che hanno goduto per alcuni decenni di buoni salari e
condizioni di lavoro, con un miliardo e mezzo di nuovi salariati che
lavorano in condizioni orrende con salari miserandi. La richiesta di
accrescere i lavori flessibili è un aspetto di tale competizione. Il
problema smisurato che la politica nazionale e internazionale dovrebbe
affrontare sta nel far sì che l’incontro che prima o poi avverrà tra
queste due parti della popolazione mondiale avvenga verso l’alto della
scala dei salari e dei diritti piuttosto che verso il basso; che è
l’esito verso cui finirebbe per condurci lo smantellamento delle
protezioni legali dell’occupazione
― uno dei tanti
sinonimi della flessibilità.
(dalla
Prefazione)
In
totale, pertanto, l’occupazione flessibile regolare e irregolare
coinvolgerebbe in Italia tra 7 milioni e 8 milioni di persone fisiche,
più 3 milioni di doppiolavoristi non dichiarati, corrispondenti a 1
milione di unità lavorative a tempo pieno. Ne segue che le persone
fisicamente coinvolte in varia misura nell’occupazione flessibile
ammonterebbero, nell’insieme, a 10-11 milioni.
Sembra
dunque di essere in presenza d’una condizione sociale più pesante e
diffusa di quanto non dicano ogni giorno gli articoli rassicuranti sulla
modesta consistenza e stabilità nel tempo del lavoro flessibile, oppure
i sagaci commenti sulla “precarietà percepita” come stato d’animo in
fondo immotivato, in quanto non corrispondente alla realtà. Dire che la
politica dell’ultimo decennio ha drammaticamente sottovalutato tale
condizione significa tenersi molto al di sotto delle righe.
(cap. 1: Le molte facce
― e i tanti numeri ― della flessibilità,
p. 25)
Pertanto, uno degli scopi essenziali della riorganizzazione produttiva
etichettata “globalizzazione” è stato, e continua a essere, quello di
sottrarre un tratto il più lungo possibile del processo produttivo alle
condizioni di lavoro predominanti nei paesi industriali avanzati;
condizioni caratterizzate da salari elevati, contratti di durata
indeterminata, vincoli legislativi al licenziamento e forti tutele
sindacali. Il rovescio di tali condizioni è stato trovato in Cina,
India, Indonesia, in altri paesi del SudEst asiatico, ma anche nei
maggiori paesi dell’ex Urss, Russia e Ucraina. In pochi lustri circa 1
miliardo e mezzo di lavoratori “globali” sono stati quindi
deliberatamente posti in competizione con i lavoratori dei paesi più
avanzati. La pressione sui salari che si avverte in Italia come in altri
paesi, e la domanda di flessibilità dell’occupazione da parte delle
imprese, stanno a significare che se non si accettano salari più bassi,
e contratti che facilitano l’uscita dei lavoratori dalle imprese, il
lavoro non importa se in forma materiale o digitale viene trasferito in
altri paesi, dove una smisurata quantità di forza lavoro è disponibile a
condizioni di gran lunga peggiori.
(cap. 2:
Alle origini della richiesta di lavoro flessibile da parte delle
imprese, p. 38)
Queste
considerazioni, mentre non fanno che confermare i dubbi del citato
rapporto Ocse 2004 circa il nesso flessibilità-occupazione, in realtà
aggiungono al tema, evidentemente senza volerlo, una connotazione
peggiorativa: i contratti a termine, che sappiamo essere per lo più
brevi, hanno un effetto negativo sulla produttività. Motivo? E semplice,
potrebbe rispondere un qualsiasi esperto di organizzazione aziendale.
Sul piano individuale, il lavoratore il quale deve pensare soprattutto a
come trovare un nuovo contratto prima che scada quello in vigore è
scarsamente motivato sul lavoro; non dispone di tempo per la formazione,
né l’impresa ha alcun incentivo a fornirgliela; infine, lascia l’impresa
prima di avere cumulato le esperienze da cui dipende in alto grado la
produttività del lavoro. Sul piano organizzativo, la presenza nella
stessa unità produttiva di lavoratori che ruotano di continuo, fra
contratti che finiscono e contratti che cominciano, e dipendenti di
aziende terze che ruotano quasi ogni giorno, limita lo sviluppo dello
scambio di conoscenze, codici verbali e non verbali, sinergie tra
competenze diverse, che sono un altro elemento essenziale della
produttività.
(cap. 3:
I dubbi rapporti tra flessibilità e occupazione, p. 55)
È
questa, in essenza, la funzione della cosiddetta deregolazione per via
legislativa del mercato del lavoro; ossia, in altre parole, dello
smantellamento della legislazione protettrice dell’occupazione, o Epl,
di cui si è già parlato nel terzo capitolo. Deregolare significa far
girare all’indietro l’orologio della storia del lavoro, in modo da
ritornare ai tempi in cui questo veniva venduto dall’individuo
all’impresa come una qualsiasi altra merce, con i soli obblighi per i
contraenti che derivano da un contratto commerciale: la merce che va
dall’individuo all’impresa deve essere della quantità e natura pattuita
ed essere fornita nei tempi prestabiliti. L’analogo vale per il denaro
che va dall’impresa all’individuo a titolo di retribuzione.
In
Italia e in altri paesi a far girare al contrario l’orologio della
storia del lavoro ha provveduto, sotto l’impulso della politica, che ha
accolto con diligenza le esigenze dell’economia, il nuovo corso
imboccato dalla legislazione sul lavoro sin dagli anni Novanta del
secolo passato. Da allora in poi essa pare essersi posta come criterio
guida quello di smontare il principio insito nella temibile affermazione
per cui il lavoro non è una merce. Così recitava il primo comma
della Dichiarazione di Filadelfia del 1944, “concernente le
finalità e il proposito della Organizzazione internazionale del lavoro”.
Organizzazione trilaterale, si noti, posto che nei suoi organi direttivi
erano e sono rappresentati governi, sindacati e imprese. In quelle sei
parole era condensato il principio per cui non può essere considerato
una merce, il lavoro, in quanto è un elemento integrale e integrante del
soggetto che lo presta, dell’identità della persona, dell’immagine di
sé, del senso di autostima, della posizione nella comunità, della sua
vita familiare presente e futura.
(cap. 4:
Il ruolo della legislazione sul lavoro, pp 58 – 59)
A
rigore, la prima tappa in direzione della rimercificazione del lavoro
non è stata una legge. Si tratta del protocollo d’intesa tra governo,
sindacati e organizzazioni dei datori di lavoro sottoscritto dalle parti
il 23 luglio 1993, che merita di essere qui richiamato perché ha aperto
la porta, e indicato con precisione la strada, alle successive leggi e
decreti indirizzati ad accrescere la flessibilità dei rapporti di
lavoro. Il protocollo, alla sezione Politiche del lavoro,
impegnava il governo a predisporre “un organico disegno di legge per
modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del
lavoro, al fine di [...] valorizzare le opportunità occupazionali che il
mercato del lavoro può offrire se dotato d’una più ricca strumentazione
che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei”. La
sottosezione dedicata alla Riattivazione del mercato del lavoro
prevedeva che le parti sociali avrebbero potuto “contrattare appositi
pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione
professionale” (comma a). Assicurava che si sarebbe proceduto “ad
una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di
orario” (comma c). Sosteneva che “per rendere più efficiente il
mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro Paese il lavoro
interinale” (comma d). Stabiliva che “forme particolari di tempo
determinato [...] possono essere previste in funzione della promozione
della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità”
(comma e).
Pochi
mesi dopo, l’idea alla base del protocollo che mediante le misure in
tema di flessibilità del lavoro da esso previste si possa produrre
occupazione sarebbe stata definita “palesemente obsoleta” in un articolo
di Massimo D’Antona [...]. Ma qui preme richiamarla per un altro motivo:
di fatto l’apertura concessa ai pacchetti di flessibilità, al lavoro
interinale (ovvero in affitto), alla modulazione degli orari al fine di
modernizzarli, recava con sé nello sfondo, quali che fossero le
intenzioni e il grado di consapevolezza dei contraenti, sindacati
inclusi, la concezione che il lavoro è un oggetto diverso e indipendente
dalla persona del lavoratore. In quanto tale, è passibile di cessioni e
vendite che lo separano senza alcuna difficoltà dal suo proprietario, al
pari d’un qualsiasi altro oggetto commerciabile.
La seconda tappa in direzione d’una ri-mercificazione del lavoro è stata
la legge 24 giugno 1997, n. 196, che avrebbe dato piena attuazione alle
indicazioni del protocollo del 1993. Detta anche “pacchetto Treu” perché
comprendeva provvedimenti di vario genere in ordine al mercato del
lavoro, era intitolata Norme in materia di promozione
dell’occupazione; titolo da annotare, poiché da esso traspariva di
nuovo la convinzione del legislatore che una maggior flessibilità dei
contratti di lavoro favorisca l’aumento del numero degli occupati. La
maggior novità della legge 196 è stata l’istituzione del contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo (art. 1)
― leggasi lavoro
interinale, cioè in affitto. In forza di tale articolo, che ha inferto
un primo grave vulnus alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,
vietante l’intermediazione, cioè l’interposizione di terzi, nel rapporto
tra il lavoratore e l’impresa, i lavoratori, come si è appena notato,
vengono assunti da un’impresa, denominata “fornitrice”, però lavorano
presso un’altra, detta “utilizzatrice”.
(cap. 4:
Il ruolo della legislazione sul lavoro, pp 63 – 65)
Pur con
le suddette connotazioni negative, rimaneva però un vantaggio nei
contratti sortiti dal pacchetto di provvedimenti del 1997: la maggior
flessibilità del lavoro che veniva introdotta era pur sempre inserita
nei contratti nazionali di categoria. I lavori flessibili venivano
considerati come eccezione rispetto all’orario a tempo pieno e
all’impiego di durata indeterminata che costituivano la norma per la
categoria. Inoltre, erano soggetti ai cosiddetti limiti di contenimento:
in altre parole, un’impresa poteva usare il lavoro temporaneo o il
lavoro a tempo parziale (regolato anch’esso dall’art. 13) entro una
quota limite che poteva andare dal 5 al 10 per cento o poco più del
totale dei dipendenti, a seconda della localizzazione dell’azienda (con
il Mezzogiorno si era un po’ più elastici), del periodo dell’anno e
delle esigenze produttive. Vi era dunque un limite quantitativo,
previsto dai contratti, alla possibilità di impiegare lavori flessibili.
Un salto netto verso la moltiplicazione dei lavori flessibili si è
verificato con il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, che
muovendo da una direttiva europea ha di fatto liberalizzato i contratti
di lavoro a termine. Pilastro di questo decreto è l’art. 1, che
stabilisce: “È
consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo”. Qualunque imprenditore o dirigente
d’azienda che non sia del tutto incapace è in grado, in qualunque
circostanza, e quale che sia la situazione dell’impresa, di esibire una
miriade di ragioni di tal genere. Ma l’aspetto peggiore non è qui il
contratto che si stipula con una data di scadenza predefìnita; è
piuttosto la ripetibilità senza fine, a carico della stessa persona, dei
contratti a termine, a condizione che il datore di lavoro badi, come
prevede il decreto, a far trascorrere almeno venti giorni tra la fine
del precedente e la stipula del susseguente. Con il contributo di tale
decreto, i dipendenti assunti con un contratto a termine sono saliti in
un decennio di circa 600.000 unità, da 1,5 milioni nel 1996 a 2,1
milioni a inizio 2007. In particolare, i diversi tipi di contratto di
dipendente a termine (li abbiamo visti supra, al cap. 1), insieme
con i contratti da parasubordinati che recano infallibilmente una data
di scadenza come le collaborazioni continuative e il lavoro a progetto,
sono diventati il tipo di contratto offerto in oltre la metà dei casi
― che in numerose
regioni diventano due terzi
― ai giovani in
cerca di prima occupazione.
(cap. 4:
Il ruolo della legislazione sul lavoro, pp 68 – 69)
I
lavori flessibili comportano rilevanti costi personali e sociali, a
carico dell’individuo, della famiglia, della comunità. Ciò avviene
perché tali lavori non sono soltanto un modo diverso di lavorare,
coerente con le esigenze della nuova economia. Sono un modo di lavorare
che rispetto al lavoro “normale”
― che indubbiamente
aveva e ha i suoi costi per le persone
― impone oneri di
natura insolita, in gran parte ancora inesplorati. Simili costi non si
possono sottacere, o dar per scontato che non esistano, adducendo a
motivo che un numero crescente di persone, in specie giovani, sembra
ormai accettare senza drammi di svolgerli, o anzi dichiara di gradirli.
Anzitutto ci sono tanti altri, giovani e non giovani, per i quali i
contratti a termine, le collaborazioni dette continuative ma in realtà
discontinue, il lavoro intermittente, a chiamata, on the road o
semplicemente occasionale, oppure in nero
― abbiamo visto
quanti siano i nomi della flessibilità
― sono percepiti,
alla lunga, come una ferita dell’esistenza, una fonte immeritata di
ansia, una diminuzione di diritti di cittadinanza che si solevano dare
per scontati.
In
secondo luogo, il lavoro che si fa oggi è capace di presentare i conti
anche tra dieci o vent’anni: quando la giovinezza sarà passata, e le
lacune di formazione, i progetti di vita rinviati e mai realizzati, le
esperienze professionali frammentarie che caratterizzano i lavori
flessibili protratti per lungo tempo comporranno un curriculum
dinanzi al quale un responsabile dopo l’altro delle “risorse umane”
(espressione ingrata da applicare a persone, giacché le definisce come
mezzi) scuoterà mestamente il capo.
Il maggior costo umano dei lavori flessibili è riassumibile nell’idea di
precarietà. Essa prende forma e sostanza, per una persona, attraverso
l’inserimento in una lunga sequenza di contratti lavorativi di durata
determinata
― mediamente di
pochi mesi
― senza alcuna
certezza di riuscire a stipulare un nuovo contratto prima della fine di
quello in corso o subito dopo; oppure di ottenere, scontando un’attesa
magari lunga e però misurabile, un contratto di lavoro di durata
indeterminata. Il termine “precarietà” non connota dunque la natura del
singolo contratto atipico, bensì la condizione sociale e umana che
deriva da una sequenza di essi nonché la probabilità, progressivamente
più elevata a mano a mano che la sequenza si allunga, di non arrivare
mai a uscirne. Nessun settore dell’economia e del mercato del lavoro
sfugge a tale regola. La precarietà oggi è dappertutto, scriveva già
tempo addietro, lungimirante, Pierre Bourdieu.
Di conseguenza, precarietà implica primariamente insicurezza oggettiva e
soggettiva. Insicurezza che muovendo dalle condizioni di lavoro diventa
insicurezza delle condizioni di vita, generata dal fatto che il lavoro,
e con esso il reddito, è revocabile a discrezione del soggetto
― l’impresa, il
datore di lavoro
― che lo ha
concesso. L’etimo di “precario” è precisamente questo: qualcosa che si
può fare solamente in base a un’autorizzazione revocabile, poiché è
stato ottenuto non già per diritto, bensì tramite una preghiera. Per
quanto attiene al mondo della vita dei lavoratori, una simile situazione
della persona che cerca un’occupazione, o vorrebbe mantenerla, pareva
definitivamente superata dalla modernizzazione; il lavoro precario ha
provveduto a riportare indietro di generazioni le condizioni di quel
mondo.
Al
proposito qualcuno ha giustamente scritto che con la diffusione dei
contratti precarizzanti, a danno dei contratti di lavoro di durata
indeterminata fino a qualche tempo fa considerati normali, è stata la
stessa normalità del lavoro e della vita a venire revocata. Una
condizione che col tempo finisce per investire e modificare anche la
mente, il foro interiore. Coloro che trascorrono nella precarietà lunghi
periodi finiscono con il percepire se stessi in modo diverso dagli
altri. Sviluppano nuovi atteggiamenti e linguaggi. Magari si difendono
dalla disperazione con l’ironia, rivolta al mondo delle imprese che
trasferiscono i propri rischi economici ai lavoratori offrendo lavori
precari, ma anche a loro stessi. Un aspetto che non si trova nelle
ricerche, ma è testimoniato dalla crescente letteratura sulla
precarietà.
La precarietà oggettiva, soggettivamente esperita, presenta vari
aspetti. Il primo va visto nella limitata o nulla possibilità di
formulare previsioni e progetti sia di lunga sia di breve portata
riguardo al futuro
― quello
professionale, ma spesso anche quello esistenziale e familiare. Per
chiunque abbia un’occupazione flessibile, simile limitazione della
possibilità di progettarsi l’esistenza può arrivare per due vie: a)
quando il soggetto sa che la sua occupazione è a termine, in forza di
dispositivi contrattuali o d’una pendente liceità dell’impresa a
deciderlo, non importa che codesta occupazione sia lunga alcuni giorni o
qualche anno; b) quando il lavoro è esposto a variazioni
temporali contingenti, ossia imprevedibili per il soggetto. Capita
inoltre, in casi non infrequenti, che le due vie arrivino a combinarsi,
di modo che la possibilità di costruirsi e perseguire progetti di vita
viene pressoché vanificata.
Un
aspetto della precarietà collegabile al precedente, al pari di esso
derivante dall’eccessiva esposizione a lavori flessibili, eppur diverso,
è il senso che la propria vita, il proprio destino, il futuro subiscono
quotidianamente l’impatto di fattori puramente contingenti. Procedono in
una certa direzione, ma questa può mutare all’improvviso per cause che
non dipendono in alcuna misura dal modo in cui il soggetto agisce.
Sembrano dipendere dall’istante e dal luogo, ambedue casuali, in cui
capita di varcare una certa porta, come nel film Sliding Doors
(Porte scorrevoli), o dall’impresa dove al momento capita di avere un
posto di lavoro in Emilia o in Basilicata, le maestranze della quale
vengono improvvisamente a sapere che chiuderà entro pochi mesi o sarà
delocalizzata in Transilvania. E al fine di riprendere il controllo
delle direzioni in cui sembra girovagare la propria vita non serve
affidarsi ad altri. Sotto questo aspetto la precarietà delle vite
flessibili è un efficace alimento dell’antipolitica, dell’astensionismo
elettorale, della resa all’esistente che si compendia in battute della
serie “sono tutti uguali” o “la tal cosa non è né di destra né di
sinistra”. Che in tali battute indulgano anche amministratori pubblici,
e perfino politici di professione, attesta soltanto in qual misura essi
hanno interiorizzato la precarietà della vita dei loro amministrati ed
elettori.
Un altro
aspetto ancora della precarietà va visto nel fatto che, al di fuori
delle professioni comportanti qualifiche molto elevate, che sono sempre
spendibili agevolmente sul mercato del lavoro, la maggior parte dei
lavori flessibili non consente di accumulare alcuna significativa
esperienza professionale, trasferibile con successo da un datore di
lavoro all’altro. Detto altrimenti, essi non permettono all’individuo né
di costruirsi una carriera, né un’identità lavorativa. Ma quest’ultima
non è un elemento supplementare o accessorio dell’identità personale e
sociale: è il suo fondamento stesso. Dell’essere umano è costitutivo il
bisogno di poter dare una risposta definita sia alla domanda interiore
“chi sono?”, sia alla domanda pubblica “chi sei?”. Dalla risposta alla
domanda interiore dipende l’idea che un soggetto ha di se stesso,
l’atteggiamento che reca verso il proprio sé. Dalla risposta alla
domanda pubblica dipende l’idea e l’atteggiamento che gli altri, quasi
tutti coloro con cui viene in contatto, avranno verso di lei o verso di
lui. Nel complicato percorso tra l’adolescenza e l’età adulta, tra la
giovinezza e la maturità, per la maggior parte delle persone lo
strumento più efficace per costruirsi una risposta ai due quesiti rimane
il lavoro che si fa, o meglio che per lungo tempo si è fatto. Non
arrivare a costruirla perché si sono fatti troppi lavori differenti,
discontinui, cento volte interrotti in un luogo e ripresi altrove, è per
molti una sofferenza, un costo umano in nessun modo computabile, e
nondimeno greve a portare.
Alla
base dei vari aspetti della precarietà testé richiamati v’è un processo
ben determinato: la moltiplicazione dei lavori flessibili tende a
erodere la maggior parte delle forme di sicurezza che l’Organizzazione
internazionale del Lavoro ha proposto tempo addietro per definire il
cosiddetto “lavoro decente” o “dignitoso”. Nel 1999 si svolse a Ginevra
l’assemblea annuale dell’Organizzazione e il rapporto del direttore
generale s’intitolava appunto Pour un travail décent. In questo
rapporto venivano delineate sette forme base di sicurezza economica e
sociale che dovrebbero venire assicurate a tutti i lavoratori. Mi
limiterò a ricordarne alcune, con qualche adattamento e un’aggiunta
rispetto al testo originale.
Sicurezza dell’occupazione,
che significa non solo protezione contro i licenziamenti abusivi, ovvero
senza causa, ma anche stabilità dell’occupazione compatibile con
un’economia dinamica.
Sicurezza professionale,
che implica la possibilità di valorizzare la propria professione
accrescendo via via le competenze tramite il lavoro e formandosi una
riconoscibile e stabile identità professionale.
Sicurezza sui luoghi di
lavoro, che
comprende la protezione contro gli incidenti e le malattie professionali
grazie a un’adeguata regolazione in tema di salute e sicurezza, che
preveda anche limiti agli orari e agli straordinari, nonché la riduzione
dello stress sul lavoro.
Sicurezza del reddito,
ovvero creazione e mantenimento d’un reddito adeguato, in grado di
assicurare al lavoratore e ai suoi familiari la copertura dei “costi
dell’uomo” a fronte d’un dato livello di sviluppo sociale.
Sicurezza di
rappresentanza,
che rinvia alla garanzia offerta dalla possibilità di espressione
collettiva sul mercato del lavoro grazie a organizzazioni sindacali
libere e indipendenti, nonché ad altri organismi capaci di rappresentare
gli interessi dei lavoratori.
Sicurezza previdenziale,
ovvero possibilità di assicurarsi attraverso il lavoro un reddito che
permetta di mantenere, dopo l’uscita dal lavoro, un livello di vita
comparabile a quello precedente. Questa forma di sicurezza non compare
nell’elenco originale dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
La
moltiplicazione dei lavori flessibili erode una parte notevole delle
citate sicurezze. Riduce, per definizione, quella relativa alla
stabilità dell’occupazione, mentre la formazione e la valorizzazione
della professionalità e dell’identità lavorativa, come si è già notato,
sono rese difficili dalla varietà di ambienti lavorativi, esperienze
tecniche, modelli di organizzazione del lavoro cui è esposto il
lavoratore flessibile.
La sicurezza nei luoghi di lavoro
― che in questo caso si
riferisce alla sicurezza
fisica, alla salute
― è compromessa dai
lavori flessibili, in specie quelli implicanti contratti di breve
durata, perché le imprese non hanno alcun incentivo a investire nella
formazione alla sicurezza di lavoratori che nel volgere di poche
settimane o mesi non saranno più alle loro dipendenze. Quanto ai
lavoratori, essi non hanno né il tempo per apprendere i codici della
sicurezza nell’impresa dove saranno occupati per breve tempo né la
motivazione a farlo. Un altro aspetto è stato ripetutamente richiamato
da ricerche svolte in diversi paesi. Chi lavora con un contratto atipico
inclina a ridurre le attenzioni per la propria salute. Pospone, ad
esempio, l’opportunità di sottoporsi a una visita medica alla necessità
di essere presente sul posto di lavoro, sperando così di accrescere, o
almeno non diminuire, la probabilità di vedersi rinnovato il contratto
che sta per scadere. Sottovalutare il proprio stato di stress, o
trascurare una visita per recarsi al lavoro, o recarsi al lavoro sebbene
indisposti, incide alla lunga sullo stato di salute.
Il
lavoro flessibile intacca fortemente la sicurezza e il livello di
reddito. Per quanto riguarda le due categorie più ampie di lavoratori
atipici, i dipendenti a tempo determinato e i collaboratori coordinati o
a progetto, che sono formalmente degli autonomi, le ricerche confermano
che essi hanno un reddito netto annuo notevolmente inferiore sia a
quello dei dipendenti con un contratto standard, sia a quello dei
veri autonomi. Una vasta rilevazione condotta nel 2005 indica che i
dipendenti a tempo determinato guadagnano in media solo l’80 per cento
della retribuzione netta di quelli a tempo indeterminato; la percentuale
scende al 66 per cento per i collaboratori. Ne risulta la seguente
scala: 15.324 euro netti all’anno (1.279 al mese) per i dipendenti a
tempo indeterminato; 12.438 euro all’anno (1.037 al mese) per i
dipendenti a termine; 10.191 euro (849 al mese) per i collaboratori. Al
confronto dei “veri” autonomi, questi ultimi stanno anche peggio:
infatti il loro reddito netto tocca appena il 43 per cento dei primi.
La causa
principale di simili dislivelli è evidente. I suddetti contratti atipici
comportano in molti casi, talora per anni di seguito, non i normali 12
mesi di lavoro, o meglio 11 mesi di lavoro più uno di ferie retribuite,
più la tredicesima, arrecanti al lavoratore 13 mensilità effettive di
retribuzione. Possono voler dire piuttosto 89 mesi di lavoro, quindi non
più di tanti di retribuzione piena. Questo accade ovviamente quando chi
appartiene a tali categorie vede scadere un contratto a termine, non
importa se da dipendente o da collaboratore, e non ne trova un altro se
non dopo settimane o mesi. Ma succede anche, con peggiori effetti, per
altre categorie di atipici; ad esempio quando uno è assunto a tempo
indeterminato da un’impresa utilizzatrice, perché alla retribuzione
piena egli avrà diritto soltanto quando si è chiamati da un
utilizzatore. Va ricordato infatti che nel decreto attuativo della legge
30/2003 è previsto che le imprese di somministrazione corrispondano il
salario intero e i relativi contributi di legge dovuti quando il
lavoratore trova effettiva occupazione presso un utilizzatore, mentre
nel periodo tra un’occupazione e l’altra al lavoratore spetta solamente
un’indennità di disponibilità, divisibile, si noti, in quote orarie, sì
da renderla proporzionale ai tempi di constatata inattività. Nei decreti
del ministero del Lavoro essa è stata indicata, a partire dal 2003, in
350 euro mensili per il lavoro in somministrazione, con incrementi
minimi di anno in anno. Nel caso del lavoro intermittente l’indennità
scende al 20 per cento del salario medio (corrispondente a circa 250
euro) dei dipendenti dell’utilizzatore. In tutti questi casi i
contributi sono corrisposti in proporzione ai periodi effettivamente
lavorati.
Fatto
riguardo a sua volta alla sicurezza della rappresentanza sindacale, a
diminuirla drasticamente provvedono, in mutevoli combinazioni, vari
fattori connessi alla flessibilità del lavoro: la mobilità dei
lavoratori flessibili da un posto all’altro; la separazione del
lavoratore dall’impresa in cui presta la sua attività, che è insita nel
lavoro in affitto o in somministrazione; l’individualizzazione dei
rapporti di lavoro promossa dalle riforme del mercato del lavoro; i
trasferimenti di rami d’azienda da una regione all’altra oppure
all’estero.
In parallelo alla riduzione delle sicurezze attinenti all’occupazione,
al reddito e all’ammontare dei relativi contributi, si riduce
inevitabilmente anche la sicurezza previdenziale. Secondo calcoli
recenti, chi ha cominciato a lavorare con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa fin dal momento della moltiplicazione di
questi, verso la metà degli anni Novanta, quando avrà raggiunto i 60
anni e al tempo stesso
― caso assai
improbabile
― le 35 annualità
contributive piene, potrà contare al massimo su pensioni corrispondenti
al 37 per cento della sua retribuzione, che come s’è visto sopra
è in media assai più bassa di quella dei lavoratori dipendenti. Per
farsi un’idea realistica della pensione cui vanno incontro questi
soggetti basta moltiplicare 849 (il reddito mensile medio rilevato di
questi soggetti) per 0,37: fa 314 (euro).
L’elenco
delle sicurezze relative a occupazione, reddito, rappresentanza
sindacale e altro elaborato dall’Organizzazione internazionale del
lavoro non rappresenta semplicemente una sorta di carta dei diritti
morali dei lavoratori. La stessa Organizzazione, attraverso un suo
programma specifico, ha avviato infatti delle ricerche in numerose
imprese dell’Unione Europea e di altri paesi. A tale fine le suddette
sicurezze sono state “operazionalizzate”, ossia trasformate in parametri
misurabili, che si possono applicare sia a livello di impresa, sia a
livello nazionale. Si comincia pertanto a disporre di basi di dati
globali sulle varie forme di sicurezza che distinguono, in misura
variabile, il lavoro decente da quello che non può dirsi tale.
Anche
gli effetti di tipo psicologico o psicosociale della flessibilità sono
da tempo oggetto di studi mirati. La precarietà del lavoro tende, alla
lunga, a venire interiorizzata dalle persone, non solo nel senso
generale sopra richiamato, ma anche sotto uno specifico profilo clinico,
suscettibile di differire da un soggetto all’altro. Può favorire in
determinati casi lo sviluppo di processi che incidono negativamente
sulla struttura della personalità e quindi del comportamento. Laddove
l’incertezza diventa una norma, essa può avere tra i suoi effetti anche
la fragilizzazione dei “puntelli” che la persona ha bisogno di trovare
in famiglia e nella collettività. Psicologi e sociologi francesi hanno
prodotto studi inquietanti su ciò che avviene a individui, famiglie e
anche ragazzi e giovanissimi in presenza d’una marcata e prolungata
insicurezza.
A tale
proposito si comincia a parlare di “figli della precarietà”, i quali
peraltro potrebbero anche esser chiamati “figli della globalizzazione”.
Sono i giovanissimi che crescono entro famiglie dove ambedue i genitori
sperimentano da lungo tempo un’insicurezza lavorativa pronunciata, non
necessariamente correlata a un reddito basso, ma con l’assillo continuo
di trovare un altro lavoro allorché quello in corso terminerà. Questi
giovani manifestano disturbi della personalità rilevanti, relativi a una
formazione incompleta o inadeguata della stessa, da cui tendenze
comportamentali che oscillano tra la resa e la rivolta senza scopo, tra
il rinchiudersi in se stessi e il ricorso alla violenza. I giovani che
scelgono la prima soluzione sono socialmente poco visibili, se non forse
alle assistenti sociali, agli operatori di comunità, alle organizzazioni
caritative. Quelli che scelgono la seconda contribuiscono invece
visibilmente alla cronaca nella scuola, negli stadi, nelle periferie, in
Italia come in Francia o in Germania.
(cap 5:
Dalla flessibilità del lavoro alla precarietà della vita, pp 75 –
85)
Infine,
v’è la questione delle cosiddette società intermedie. L’integrazione
dell’individuo nella società non può avvenire, se non parzialmente, in
modo diretto. All’integrazione totale e diretta degli individui con i
vertici del potere puntano solamente le società autoritarie. In una
società democratica matura occorre invece che l’individuo sia
primariamente integrato nella famiglia, nella comunità locale, in vari
generi di associazione; dopodiché sarà un’adeguata integrazione di
queste nello spazio pubblico ad assicurare all’individuo i benefici
dell’ordine sociale, come pure a tutelarlo dalle sue deviazioni. La
società flessibile, di là dal velo ideologico che vorrebbe ritrarne le
veritiere fattezze nel mentre di fatto le maschera, non sembra
particolarmente amica di nessuna di queste società intermedie. Non lo è
di fatto, perché la variabilità degli orari e dei luoghi di lavoro, di
istruzione, di tempo libero dei diversi componenti della famiglia e
della comunità locale porta inevitabilmente a erodere il legame sociale
tra di essi. Non lo è nemmeno dal punto di vista teorico, perché essa
codifica e legittima le delocalizzazioni dell’impresa come della
famiglia, il lavoro senza luogo, l’abolizione del radicamento
territoriale di ogni attività sociale.
Quanto alle associazioni, il progetto di società flessibile
― quale in concreto
ci viene presentato dal discorso politico-economico dominante
― trae in concreto
giovamento dalla crisi della più antica di esse, la Chiesa, nel mentre
teorizza e persegue l’indebolimento, se non anzi l’annullamento, della
principale tra quelle che rimangono, il sindacato. Per il modello della
società flessibile, il sindacato è l’epitome di tutti i suoi contrari:
la rigidità burocratica; la difesa dei diritti acquisiti per ascrizione
e non per merito; una delle maggiori barriere che si oppongono
all’innovazione permanente di tutte le modalità dell’agire sociale. Esso
deve essere oggetto sia d’un reciso contrasto ideologico, sia
― come sta
avvenendo in Italia
― di provvedimenti
legislativi mirati a rimuovere quest’ultimo ostacolo a che l’individuo
sia inserito direttamente, senza mediazioni, nella rete delle reti.
Affinché esso divenga, con le parole di Niklas Luhmann, unicamente un
nodo passivo dei flussi di comunicazione, inconsapevole del senso reale
dei messaggi che esso riceve e ritrasmette, ad essi totalmente alieno.
La dialettica reale tra lavoro flessibile e società flessibile, quale
emerge dalle ricerche sul campo, non pare dunque condurre nessuno dei
due elementi verso esiti particolarmente promettenti per la qualità
della vita e dell’organizzazione sociale. L’uno e l’altra incorporano
sicuramente elementi del progetto moderno
― un progetto
largamente incompiuto
― ai quali non
vorremmo rinunciare. Nondimeno, gli elementi che in essi appaiono
predominare al presente, esaltati negli ultimi decenni tanto
dall’ideologia e dall’economia neoliberali quanto dalla pratica politica
delle socialdemocrazie, ci sembrano comportare un prezzo troppo elevato
per poter accogliere insieme questi e quelli. Chi scrive pensa che
dinanzi a tale situazione ambivalente si debba essere, al tempo stesso,
discriminanti quanto esigenti. Dobbiamo saper distinguere i costi umani
della flessibilità del lavoro e della società flessibile dai loro
eventuali benefici, quanto esigere che i primi non vengano, come si
suole, ignorati o sottovalutati in nome dei secondi.
Un
compito arduo che tuttavia, se non vogliamo arrenderci al credo
interessato per cui la realtà del mondo globalizzato persegue comunque,
ad onta dei nostri sforzi, un suo indefettibile cammino, occorre
affrontare combinando la tenacia del ricercatore con la passione che
ogni cittadino dovrebbe portare alla difesa d’un bene comune essenziale.
Un bene qual è una società in cui la molteplicità degli interessi, delle
culture, delle condizioni di lavoro e di esistenza trova una
composizione armonica in forza di alcuni ideali irriducibili di
giustizia sociale, di uguaglianza, di diritti delle persone. Un insieme
di elementi costati all’Europa troppe fatiche, e troppe sofferenze, per
pensare che si possano o si debbano agevolmente alienare in nome di
nuove forme di funzionamento del sistema economico, pur nel
riconoscimento che queste richiedono appropriate riforme
dell’organizzazione sociale.
(cap 8:
Società flessibile e integrazione sociale, pp 115 – 117)
Ma in
Italia tre quarti delle forze politiche del centrosinistra hanno una
concezione meramente adattativa delle politiche del lavoro, che si
distingue da quella del centrodestra solo perché orientata a una certa
maggior disponibilità quando si tratta di curare gli effetti della
flessibilità mediante “ammortizzatori sociali”.
(cap.
10: Contro la precarietà, una politica del lavoro globale, p.
162)
|